Da Tod und Verklärung ai Vier letzte Lieder
L'Alfa e
l'Omega dell'opera di Richard Strauss
© 2022
FABIO GRASSO @ rosenfinger.com
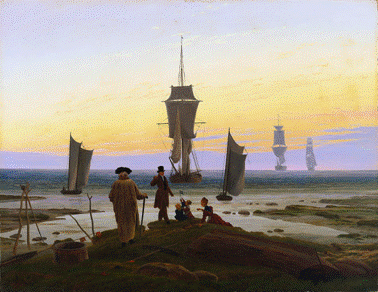
Il primo
periodo della produzione di Richard Strauss, dominato dalla stesura dei poemi sinfonici, ci
offre alcuni brani particolarmente rappresentativi del genio e dello spirito
più autentico del compositore. Culmine di questa fase è senza dubbio Tod und Verklärung -
Morte e trasfigurazione op. 24, poema sinfonico composto dal venticinquenne
Strauss nel 1889. Quasi 60 anni dopo, al termine di
una parabola creativa di straordinaria varietà, che attraversa un'epoca di
eventi storici e di mutamenti artistici quanto mai travolgenti, nel lasciarci
il suo stupefacente testamento musicale, i Vier letzte Lieder, l'autore
avverte il bisogno di fare riferimento a quel capolavoro degli esordi,
rievocando così un linguaggio che doveva sentire come sommamente congeniale.
Esponiamo
qui di seguito alcune considerazioni analitiche atte ad illustrare il legame
fra due lavori la cui distanza cronologica è inversamente proporzionale alla
contiguità spirituale.
L'intento
programmatico di Tod und Verklärung è
notoriamente quello di rappresentare musicalmente la fase terminale della vita
di un artista che, giacendo sul letto di morte, rivede il suo percorso
esistenziale e creativo fra momenti convulsamente drammatici e ricordi sereni,
per poi spirare ed entrare in una dimensione nuova, trasfigurato
nell'immortalità.
Nonostante
che il brano sia dichiaratamente concepito come sequenza di sezioni
corrispondenti alle fasi del racconto, possiamo tuttavia intravedervi una
struttura più o meno latente di movimento sinfonico dai contorni di
forma-sonata preceduta da un'introduzione lenta.
La cosa
non stupisce più di tanto, sia perché qualsiasi compositore che si forma
accademicamente in quegli anni non può non annoverare ancora l'idea
dell'architettura sonatistica fra i cardini del
proprio processo di imprinting compositivo, sia
perché i confini fra poema sinfonico e forma-sonata sinfonica possono rivelarsi
alquanto labili, come dimostra anche la storia della stesura della pressoché
coeva Prima Sinfonia di Mahler: fra l'altro quest'ultima condivide con Tod und Verklärung anche l'elegante
disinvoltura dei procedimenti di manipolazione motivica,
di sicura matrice lisztiano-wagneriana, attraverso
cui un tema si trasforma gradualmente in un altro o in svariati altri.
Ci
accingiamo dunque a delineare l'architettura formale e i percorsi di
derivazione tematica del poema sinfonico, al fine di dimostrarne la sostanziale
assimilabilità ad una forma-sonata e l'unitarietà dei
materiali.
TOD UND VERKLÄRUNG
I passi
sono segnalati tramite le lettere di riferimento o le indicazioni di movimento
della partitura. Abbreviazioni:
Rif.H = Riferimento H;
Rif.N+4 =
4 battute dopo il Riferimento N
-6_Rif.L =
6 battute prima del Riferimento L
INTRODUZIONE
(BLOCCO 0)
Nella
sezione introduttiva di Tod und Verklärung vengono
presentati tutti gli incisi motivici utilizzati per
plasmare i temi del brano, uno dei quali già esposto qui nella sua interezza.
Definiamo
A l'elemento iniziale dei ribattuti a cui sincopi e terzine acefale dànno una connotazione ritmica particolare - nell'ottica
programmatica si associa a questo ritmo l'idea del battito cardiaco del
morente, che sta progressivamente venendo meno.
Indichiamo
poi con B le coppie di accordi le cui note più acute scendono per gradi
congiunti, e con C la risposta a B, consistente nel frammento di 4a ascendente
affidato ai Flauti, tramutato successivamente in 5a ascendente.
Il primo
soggetto a presentare un profilo melodico più sviluppato è il motivo del primo
Flauto che consta di tre gradi congiunti discendenti seguiti da un salto di sesta
maggiore discendente e da altri due gradi congiunti che completano la discesa
dei primi tre. Lo identifichiamo come D, mentre denominiamo E la linea del
primo Oboe che gli fa da controcanto, costituita da
tre gradi congiunti cromatici ascendenti e da un salto di terza minore
ascendente.
Se dunque
E può già essere considerato come un conseguente di D per via della specularità dei rispettivi elementi costitutivi, ben più
chiara appare la derivazione da D del tema F, enunciato per la prima volta
dall'Oboe in La bem. min. (Rif.B):
l'intervallo di ottava, che rappresenta l'estensione globale di D, diventa in F
la distanza del salto melodico iniziale, con verso ascendente, compensato dalla
discesa per gradi congiunti, qui continua, non più interrotta come in D.
Riepiloghiamo
quanto fin qui illustrato nel seguente Esempio n. 1.

Esempio-1
L'Introduzione
si chiude ponendo particolare enfasi su D ed E, in una lunga dissolvenza che
suggella degnamente il gioco di raffinate concatenazioni armoniche e
modulazioni attraverso cui vengono giostrati i materiali sopra descritti lungo
l'intero arco di questo prologo.
BLOCCO 1 ~
prima parte di Esposizione (primo nucleo tematico e ponte modulante)
Si nota
facilmente come il tema principale dell'Allegro agitato (in Do min., come l'inizio dell'introduzione) prenda gradualmente
forma a partire da frammenti melodici di semitono e di terza minore (anche
nella veste equivalente di seconda aumentata), fino ad arrivare alla seguente formulazione
definitiva (Rif.F), che, oltre ad essere basata su tali intervalli caratteristici di E e sul salto di 5a ascendente di C, si richiama ai materiali dell'introduzione
anche per alcuni aspetti ritmici. I moti cromatici ricavati da E vengono qui reindirizzati anche in senso discendente.

Esempio-2
Questo
tema dall'andamento tumultuoso, rispecchiante tutta la drammaticità del momento
evocato dal testo programmatico, è seguito da un esteso corollario elaborativo (Rif.H) e da una rienunciazione abbreviata ancora più concitata (Rif.K).
Questa
impostazione di tipo a-b-a ricorda la tripartizione
di certi primi nuclei tematici di forme-sonata beethoveniane
e schumanniane - solo per citare due esempi
particolarmente illustri, i primi tempi delle rispettive Terze Sinfonie.
Il
convulso cinetismo di questo nucleo tematico sembra
conoscere un momento di tregua col "poco ritenuto" (-6_Rif.L) che
marca una decisa svolta armonica verso la Dominante di Mi bem
magg., senza che tuttavia la potenza delle sonorità orchestrali
venga meno; anzi il motivo che qui emerge è scolpito nel fortissimo degli
ottoni all'unisono. Si tratta di un'ulteriore importantissima evoluzione di F
(già a sua volta derivazione di D), in cui il salto di ottava viene posto in
continuità ascendente rispetto a 3 gradi congiunti, per poi ripiegare in
discesa con altri gradi congiunti.
Si tratta
della prima apparizione del motivo che si rivelerà essere quello della
Trasfigurazione, quando tornerà sublimato nel solenne Do magg. della lunga
Coda. L'Esempio 3 riporta le due versioni a confronto (si tenga conto che la
prima ha un'armonizzazione dominantica, mentre la
seconda poggia su un'armonia di Tonica).

Esempio-3
Dopo
l'enunciazione di questa nuova idea tematica un diminuendo annuncia un deciso
cambio di atmosfera: la Dominante di Mi bem magg.
viene reinterpretata come sesta aumentata da
risolvere sulla Dominante di Re maggiore, da cui, tramite doppia Dominante, si
arriva al Sol magg. che è tonalità principale del blocco successivo.
Possiamo
attribuire a questo segmento fondato sulla profezia del tema della
Trasfigurazione una funzione di ponte modulante che collega il primo nucleo
tematico al secondo, ipotesi suffragata dalla relazione tonale decisamente sonatistica fra tali nuclei (Do min. - Sol magg.).
BLOCCO 2 ~
seconda parte di Esposizione (secondo nucleo tematico)
Il
contrasto di carattere fra il Blocco 1 e il Blocco 2, rappresentazione del
conflitto fra il lacerante impatto doloroso dell'incombente ora fatale e
l'effetto consolante dei ricordi di vita più sereni, riflette la concezione
tipicamente romantica del rapporto fra primo e secondo tema della forma-sonata,
tendente ad esasperare la differenza fra le rispettive connotazioni espressive.
Protagonista
di questo blocco dai colori orchestrali tenui e trasparenti è nuovamente il
tema F (Meno mosso), in una versione mirabilmente variata da placide estensioni
narrative. Anche questo nucleo tematico, come il primo, presenta una
tripartizione simmetrica, con un corollario centrale, Leicht
bewegt, che si richiama con leggerezza e vivacità a B
e D, e una riproposizione di F ulteriormente
modificata con inserti imitativi.
Il
repentino inquietante ritorno del primo tema dell'Agitato (Rif.N+4) funge da
transizione al terzo blocco.
BLOCCHI
3-4 ~ Sviluppo
Dal punto
di vista programmatico questa coppia di blocchi è da associare alla fase in cui
le memorie di una gloriosa vita d'artista vengono a poco a poco sopraffatte dai
tormenti dell'ora estrema, non disgiunti peraltro da afflati di speranza in
proiezione ultraterrena.
La natura
marcatamente elaborativa di queste porzioni di brano
ci induce a considerarle come componenti di un vasto Sviluppo bipartito.
Il Blocco
3 si apre con una sezione (Etwas breiter)
in cui D e F ricompaiono con un inedito carattere incisivo e marziale. A
partire dall'Appassionato F si intreccia con E in un dialogo intenso e serrato,
punteggiato con frequenza sempre crescente dai ribattuti di A e dall'incipit
del primo tema.
Il Blocco
4 (Tempo I, 60ma pagina della partitura) esordisce col grandioso tema della
Trasfigurazione in La bem magg.;
le sue successive enunciazioni trasposte si alternano con una nuova
rivisitazione di E dai toni prima accorati e poi sempre più accesi, ancora una
volta sullo sfondo dell'inesorabile richiamo al primo tema. L'ultima
ripetizione del tema della Trasfigurazione in Re bem
magg. prelude a un repentino diminuendo che segna una sorta di collasso
armonico (Poco stringendo della 68ma pagina); attraverso questa sorta di
precipizio modulante si ripiomba nelle sonorità gravi e misteriose dell'inizio.
BLOCCO 5 ~
Ripresa troncata
Non deve
sorprendere che si consideri alla stregua di una Ripresa la sola
ricapitolazione parziale del primo tema; nella prassi sonatistica
romantica le Riprese tendono ad essere decurtate, tanto più pesantemente quanto
più la prospettiva strutturante diventa macroformale e coinvolge l'intera
composizione, spostandosi su un piano superiore a quello dei singoli movimenti
- il primo movimento della già citata Prima di Mahler
può essere soddisfacentemente esemplificativo in tal senso.
Appare
dunque come un inequivocabile accenno di Ripresa l'Allegro molto agitato della
71ma pagina, ultima riesposizione del primo tema,
ultimo tragico sussulto che si dissolve in una salita cromatica in diminuendo
(corrispettivo simmetrico della discesa descritta alla fine del Blocco 4),
accompagnata dal colpo di Tam-Tam, geniale trovata timbrica che a livello
programmatico evoca il momento preciso del trapasso.
CODA
(BLOCCO 6)
L'approdo
dell'anima dell'artista alla dimensione trascendente è simboleggiato
dall'estesissima Coda, che presenta caratteristiche completamente diverse dai
blocchi precedenti: i tempi sono estremamente dilatati, il tema della
Trasfigurazione è soggetto quasi unico (fatta eccezione per qualche allusione a
F), il frenetico incalzare delle modulazioni lascia qui il posto ad una
sostanziale stabilità tonale sul Do maggiore, che certo viene messa in
discussione da una lunga digressione modulante, anch'essa dall'incedere molto
solenne, ma che è poi ampiamente riaffermata nella lunga dissolvenza finale.
Notiamo come in questa ultima propaggine di brano la tonica di Do maggiore sia
il centro di gravitazione di due oscillazioni, una sul sesto grado abbassato e
una sul sesto grado; un particolare questo che sarà suggestivo ricordare
esaminando il finale del quarto dei Vier letzte Lieder.
VIER LETZTE LIEDER
Il titolo
di questa estrema esalazione di grande linguaggio tonale in pieno Novecento
(1948) rende bene l'idea di come Strauss sentisse ormai
approssimarsi la fine.
La scelta
e la disposizione dei testi (1.-2.-3. di Hesse e 4. di Eichendorff,
significativo ritorno a un gigante della liederistica
romantica) dimostra un chiaro intento narrativo macroformale: il soffio vitale
del n. 1 inizia a spegnersi col decadimento autunnale del n. 2 e con
l'assopimento del n. 3, e si estingue definitivamente nella quiete del n. 4, in
cui la serenità della coppia che cammina verso il tramonto, mano nella mano,
non può più essere turbata da alcunché, nella consapevolezza di aver raggiunto
la destinazione finale.
1. Frühling (Primavera)
Si può
affermare che ognuno dei Quattro Ultimi Lieder
presenta almeno una peculiarità compositiva che resta
impressa come fortemente connotante per il singolo brano rispetto agli altri -
questa sensazione, ovviamente, coesiste con la chiara percezione di molti
fattori comuni. Se per September l'elemento distintivo può essere la
presenza, per così dire, di due Leitmotive, per Beim Schlafengehen l'ambiguità
formale e il bipolarismo tematico, per Im Abendrot
i corposi episodi strumentali che fanno da prologo ed epilogo, oltre che
naturalmente le molte specificità di carattere di cui si dirà più avanti, per Frühling
menzioniamo senza esitazioni l'esasperazione del cromatismo e l'altissima
densità della trama modulante. Sembra quasi che alcune armonie ottengano
conferma, oseremmo dire legittimazione, solo attraverso un'oscillazione
cromatica, non per forza fra le fondamentali: basta infatti osservare la breve
introduzione orchestrale, con l'alternanza fra Dominore
e La bem min. (un collegamento che ricorre anche
nell'introduzione di Im Abendrot) per
notare che le affinità di terza vengono spesso gestite in modo da avere alti
tassi di cromatismo nei movimenti di tutte le note delle triadi coinvolte.
Anche in
ragione di un flusso armonico così cangiante e sinuoso la conseguente assenza
di stabilità fa sì che il fraseggio tenda ad essere in continua evoluzione;
questo ha ricadute anche sulla struttura complessiva, che può essere considerata
un esempio emblematico della tipologia formale durchkomponiert.
Esaminiamo
l'armonia della prima strofa:
In dämmrigen Grüften
Do min.
Träumte ich
lang
La bem min.
Von deinen Bäumen | und blauen Lüften,
Si magg. | La magg. --- 7a dim. Attrattaalla D di Si bem
Von deinem
Duft | und Vogelgesang.
Si bem magg. Mi min - Sol magg. - Mi bem magg.
In oscuri sepolcri
sognai a lungo
i tuoi alberi e le tue brezze azzurre,
il tuo profumo e il canto degli uccelli.
Già da
questa strofa traspare chiaramente la tortuosità del cammino modulante del
Lied. Solo sulla parola Vogelsang il basso scende di
cinque gradi cromatici (da Mi bem a Si beem), implicando armonizzazioni del tutto inattese, anche
quando ci si potrebbe muovere in un non così complesso ambito di affintià di terze. La discesa da Re bem
a Si bem viene armonizzata con due risoluzioni
consecutive di seste aumentate, la prima delle quali è talmente rapida da non
lasciar percepire alcun ancoraggio tonale preciso.
Perfino il
percorso delle prime modulazioni, vale a dire Do min. - La bem
min. - Si magg. - La magg. - Si bem magg. delinea una
addensamento cromatico (le cinque toniche delle tonalità menzionate formano per
così dire un cluster cromatico dell'ampiezza di due
toni), non per via lineare ma per convergenza verso il centro di simmetria Si bem.
Tenuto
conto che nelle strofe successive la densità cromatica e modulante aumenta
ulteriormente, si capisce bene come possa divenire esercizio alquanto pedante
il render conto dei dettagli, giacché occorrerebbe talvolta segnalare una
modulazione per sillaba. Ci limitiamo dunque a fornire un'idea di massima delle
principali tappe tonali di ogni strofa, rimarcando ancora una volta che
qualsiasi tipo di collegamento, sia esso semitonale, di tono o di terza o
altro, viene preferibilmente realizzato per via cromatica, determinando così
effimere modulazioni di transito su tappe intermedie.
Nun liegst
du erschlossen
In Gleiß und Zier
Von Licht
übergossen
Wie ein
Wunder vor mir.
Ora tu sei qui dischiusa
in fulgido ornamento,
inondata di luce
come un prodigio di fronte a me.
Do magg., Mi magg., Do diesis min., La magg., Si magg., Sol magg., D di Fa diesis
Du kennest
mich wieder,
Du lockest
mich zart,
Es zittert durch all meine Glieder
Deine selige
Gegenwart.
Tu mi riconosci,
tu mi attiri teneramente,
un fremito percorre tutte le mie membra,
il tuo beato presente.
La magg., Si bem magg.,
Re magg., Re bem magg., La magg., Re magg., Do magg., La magg.
Come si
può notare, la natura totalmente aperta del percorso del Lied è dimostrata
anche dal fatto che la tonalità finale è ben lontana da quella iniziale.
Esiste
tuttavia un elemento ricorrente in questa sorta di serpeggiante "melodia
infinita": un inciso tematico costituito da due intervalli ascendenti,
inizialmente stretti, divisi da un salto discendente inizialmente più ampio. Di
questa cellula si percepisce sia il ciclico ritorno, sia il continuo processo
di metamorfosi intervallare che la diversifica ad ogni apparizione, fino a
deformare radicalmente la sua configurazione di partenza.
L'Esempio
4a illustra tutte le sue manifestazioni nella prima strofa, mentre il 4b,
sintetizzando la transizione orchestrale fra seconda e terza strofa, ci mostra
a quale stadio giunge qui la sua trasformazione. Possiamo inoltre capire da qui
quanto siano ricchi di interesse armonico gli intermezzi strumentali fra una
strofa e l'altra, e quanto sia geniale il modo in cui Strauss
prende spunto da due enunciazioni consecutive dell'inciso ricorrente per darne
due interpretazioni armoniche differenti, il cui accostamento restituisce al
meglio il senso dello stupefacente utilizzo del linguaggio tonale fatto dal
compositore in questo Lied.

Esempio-4
2. September
Nel testo
del Lied n. 2 si coglie una polarità fra due seoggetti,
il giardino e l'estate, che in linea di massima sono contraddistinti da
specifici elementi motivici: le cellule in ritmo
puntato e le numerose figure discendenti (scale e arpeggi in terzine) sono
preferibilmente associate al giardino, entità poetica che incarna pienamente il
senso di discesa e di caduta che pervade il Lied - il giardino è in lutto, nel
giardino cadono foglie e gocce d'acqua, è del giardino il sogno che svanisce.
Anche l'estate è in fase di estinzione, ma pare conservare qualche labile
traccia della sua passata vitalità (il brivido, il sorriso, gli ultimi
respiri), di cui è espressione musicale il frammento motivico
della quartina di semicrome costituita da una coppia ripetuta di gradi
congiunti ascendenti.
Di grande
valenza simbolica è anche il percorso tonale complessivo del brano, quasi
specchio del concetto basilare dell'intero ciclo: dal Re magg. d'impianto si
modula a Sol magg. e poi a Si bem magg.;
quindi si ripiega su La magg. attraverso la sponda della sottoposizione di
terza su Sol bem magg. per poi iniziare una discesa
quasi interamente cromatica che da La magg. riporta infine a Re magg. toccando,
in modo più o meno compiuto, le tonalità di La bem min., Sol magg., Fa diesis min. -
magg., Mi magg. e Mi bem
magg.
La
gradualità della caduta descritta da questo arco modulante si ritrova anche
nell'ultima sezione in Re magg., dove la quartina di
semicrome del motivo dell'estate viene allargata in terzine di crome, quando il
giardino chiude definitivamente gli occhi, appesantiti da una stanchezza del
cui insorgere anche il raffinato aggettivo "müdgewordnen"
(letteralmente "diventati stanchi") sottolinea la lenta
progressività.
Der Garten
trauert,
kühl sinkt
in die Blumen der Regen.
Re
maggiore
Il giardino è in lutto,
fresca scende tra I
fiori la pioggia.
Der Sommer
schauert
Sol magg., prima apparizione del motivo della quartina di
semicrome
still seinem
Ende entgegen.
Si bem magg.
L’estate ha un brivido
Andando
silenziosa incontro alla sua fine.
Golden tropft Blatt um Blatt
Sol bem magg.
nieder vom
| hohen
| Akazienbaum.
Sol bem magg
| La magg.| La bem min.
Come gocce dorate cadono le foglie una a una
giù dall’alto albero di acacia.
Sommer lächelt
erstaunt und matt
Sol magg.
in dem | sterbenden | Garten-------------- traum.
Fa diesis min.| Fa diesis magg. Mi
magg.
L’estate sorride attonita e sfinita
nel sogno morente del giardino
Lange noch
| bei den Rosen
Mi magg.| Mi bem magg.
bleibt er
stehen, | sehnt sich nach
Ruh.
Mi bem magg.| Re magg.
Ancora a lungo sulle rose
s’intrattiene, anela alla pace.
Langsam tut
er die großen
müdgewordnen Augen
zu.
Re
maggiore
Lentamente chiude i grandi
occhi ormai esausti.
3. Beim Schlafengehen
(Andando a dormire)
Se per i Lieder n. 1 e 2 il modello formale durchkomponiert
appare fuori discussione, per il n. 3 e
in parte anche per il n. 4, come si vedrà, la valutazione è un po' più incerta.
L'introduzione
orchestrale del n. 3 si fonda su una linea per gradi congiunti diatonici
discendenti, organizzati però in gruppi di 2 o di 3, con spostamenti all'ottava
superiore nel passaggio da un gruppo all'altro (cioè il moto discendente per
gradi congiunti è spezzato da salti di settima ascendente).
Dunque,
dopo tanto cromatismo dei n. 1 e 2, sebbene anche in questo Lied non manchino
modulazioni di densità cromatica ragguardevole, colpisce la tendenza al diationismo del materiale d'esordio, quasi un segnale
d'ingresso nella seconda metà del ciclo, una svolta verso l'aura di serena
rassegnazione evocata dai testi dei n. 3 e 4, che porta con sé un allargamento
dei tempi, un certo rallentamento dei flussi armonici e una relativa
attenuazione dei loro precedenti turgori. Beninteso, non si va verso un reale
abbattimento del cromatismo; ma certamente il pur ricco cromatismo di alcuni
celeberrimi passi di Im Abendrot
acquista, con la dilatazione del fraseggio, un sapore del tutto diverso da
quello di Frühling.
Su questa
linea che possiamo definire tema del prologo si innesta come naturale
prosecuzione la melodia vocale della prima strofa.
Nun der Tag mich müd gemacht,
Soll mein
sehnliches Verlangen
Freundlich die gestirnte
Nacht
Wie ein
müdes Kind empfangen.
Ora il giorno mi ha reso stanco;
accolga il mio ardente anelito,
affettuosamente, la notte stellata,
come un bambino stanco
L'amplificazione
del grado congiunto discendente avviene in senso inverso nella voce col
suggestivo salto di 9a minore su gestirnte Nacht, un passaggio questo che sembra voler confermare la
tonalità di La bem magg. dopo un inizio fluttuante
tra Fa min. e Re bem magg.,
e che invece prelude ad un Mi magg. raggiunto per effettiva sottoposizione di
terza, e subito lasciato per Do diesis min. attraverso una discesa cromatica
del basso (Mi - Mi bem - Re - Do diesis), armonizzata
con due seste aumentate tedesche parallele su Mi bem
e Re - significativa soprattutto quest'ultima per la
sua risoluzione diretta su una tonica, prassi peraltro già ampiamente esplorata
in età romantica, ma qui di particolare interesse per il tocco di eleganza col
quale, grazie al contesto cromatico, la tradizionale forza tensiva
dell'accordo viene stemperata in una dolce ed elegiaca seppur breve
transizione, che collega immediatamente la fine della frase vocale all'inizio
della seconda strofa.
Hände, lasst
von allem Tun,
Stirn, vergiss
du alles Denken,
Alle meine Sinne nun
Wollen sich
in Schlummer senken.
Mani, cessate ogni agire,
Fronte dimentica ogni pensiero,
Tutti i miei sensi ora
Vogliono sprofondare nel sonno
In
apertura della seconda strofa Il tessuto strumentale elabora le discese
diatoniche per gradi congiunti, approdando a Re magg. sul secondo verso; da qui
una connessione cromatica irta di dissonanze (meine Sinne) conduce a Si bem magg.
L'inabissamento dei sensi viene reso con ulteriori scivolamenti verso il basso
della traiettoria tonale: Sol min., Re min. e infine
Re bem magg., punto di
arrivo di importanza capitale nell'architettura del Lied.
A
compensare l'assenza di un intermezzo strumentale fra le prime due strofe
appare, come momento di stacco fra la seconda e la terza un ampio episodio orchestrale:
dal Rif.C (Sehr ruhig) una struggente melodia solistica del Violino primo
riecheggia con lampante evidenza il tema del prologo, e a Rif.D
ne fa scaturire un nuovo tema di prodigiosa bellezza, che quasi a rendere
l'idea dell'appagamento generato da una mèta raggiunta, non abbandona più la
tonalità di Re bem magg. se non per deviazioni
passeggere.
Potremmo
definire questa perla come tema del sogno, dal momento che introduce i
contenuti della terza e ultima strofa.
Und die Seele, unbewacht,
Will in freien Flügeln schweben,
Um im Zauberkreis
der Nacht
Tief und tausendfach
zu leben.
E l'anima incustodita
vuole librarsi su libere ali,
per vivere, nel cerchio incantato della notte
la profonda pienezza di innumerevoli vite.
Il canto
raccoglie lo spunto del Violino solo e ne ripercorre l'intera linea,
arricchendola di efflorescenze melismatiche in
quantità ben superiore rispetto a qualunque altro luogo del ciclo. Una cospicua
porzione del tema del sogno viene riproposta dalla voce sulle sole due parole Flügeln schweben; quindi lo
scambio di ruoli fra voce e Violini primi alla fine del secondo verso
restituisce la conclusione del tema agli strumenti da cui era nato. Così come
nella prima strofa, anche qui sulla parola Nacht la
voce dilata in nona un grado congiunto discendente, come per far risaltare
quanto sia profonda l'immersione in questa notte incantata dalla chiarissima
valenza metaforica. Un ultimo appassionato richiamo al tema del prologo
conclude il Lied, sempre in Re bem magg., che di fatto resta stabile per l'intera terza
strofa: considerata l'elevatissima concentrazione di modulazioni a cui ci si
abitua ascoltando i primi due Lieder questa fissità
lascia attoniti, e fa pensare a questa strofa come a una sorta di finale
anticipato del ciclo, un commiato dal testo di Hesse,
che, al di là dei diversi autori delle poesie, fa avvertire nella macroforma
musicale una forte cesura fra i Lieder 1-2-3 e il 4.
Alla luce
di quanto detto si spiega la natura ibrida della forma di Beim Schlafengehen: se indichiamo con TP il
tema del prologo e TS quello del sogno, lo schema strutturale del brano
potrebbe essere il seguente:
TP -
estensione di TP (Strofa 1)
Libero
sviluppo di TP (Strofa 2)
TP variato
-TS (Intermezzo fra Strofe 2 e 3)
TP diversamente
variato - TS - TP ancora variato
Certo non
si colgono mai ripetizioni identiche o molto somiglianti, come accade nelle
forme strofiche o nei vari tipi di Lied-Form, ma
altrettanto sicuramente la percezione di sezioni riprese, per quanto modificate,
è qui decisamente forte, soprattutto per quanto riguarda la componente TS. Si
può dunque dire che la concezione del brano durchkomponiert
viene significativamente contaminata dall'idea della stroficità,
sia pure molto variata.
Va da sé
che può sembrare cavilloso cercare ad ogni costo di incasellare in un modello
questi frutti di una genialità libera e ormai completamente disinibita; ma non
lo si fa per smania di classificazione, bensì per mostrare quanto anche i
dettagli della ricerca formale possono contribuire alla riuscita di un'impresa
così ambiziosa quale è la creazione di un rivestimento musicale adeguato a
testi di cotanta potenza espressiva.
4. Im Abendrot (Al
tramonto)
Ci
riallacciamo all'argomentazione formale per avviare il discorso sul Lied n. 4,
che ome il n. 3, per quanto in misura minore, mette
in dubbio l'unidirezionalità della campata unica e
continua tipica dell'approccio durchkomponiert inserendo un inequivocabile accenno di
ripresa dell'inizio, pur soltanto
parziale. Vedremo fra poco quanto questa scelta sia funzionale alla magistrale
interpretazione musicale del substrato concettuale del testo di Eichendorff.
Il Lied è
aperto da una lunga introduzione orchestrale di 20 battute, occupata da una
melodia di ampio respiro, che possiamo definire come Tema 1. L'itinerario
modulante procede per affinità di terza, muovendosi fra la tonalità d'impianto
Mi bem magg. e Do min., La bem min. e Do bem magg.
Notiamo a
b.8 e 10 le coppie di gradi congiunti ascendenti che,
pur con una ritmica completamente diversa, richiamano il profilo melodico del
motivo dell'estate in September.
- Prima Strofa (b.21-33)
Wir sind
durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand
Siamo giunti attraverso il dolore e la gioia
mano nella mano;
Proseguono
le relazioni armoniche di terza, qui in senso inverso rispetto
all'introduzione, dato che il Mi bem magg. di base si
alterna a Sol min. e Sol bem. Magg.
vom Wandern
ruhen wir beiden
Nun überm stillen Land.
entrambi ora ci riposiamo del viaggio,
in questa terra silenziosa.
L'ultimo
verso va da Mi bem magg. alla Dominante Si bem magg., descrivendo la prima
modulazione cruciale per la struttura del Lied, come si capirà in seguito.
Giova per
inciso sottolineare, osservando la relazione fra voce e archi del terzo verso, quanto
spesso la linea vocale appaia
profondamente integrata nel tessuto strumentale, cosa che emerge con
evidenza anche in passi dei Lieder precedenti.
- Seconda
Strofa (b.35-43)
Rings sich
die Täler neigen,
Es dunkelt
schon die Luft,
Intorno digradano le valli,
l’aria già si fa scura;
La strofa
ricomincia immediatamente a proporre collegamenti armonici per terze, passando
dal Si bem magg. di approdo della Prima Strofa al Sol
bem magg. che diviene enarmonicamente
Fa diesis min.
La linea
vocale sembre riprodurre una variante dell'incipit
del Tema 1, ricalcandone poi l'andamento discendente, in sintonia col verbo neigen.
Zwei Lerchen
nur noch steigen
Nachträumend in den Duft.
solo due allodole ancora spiccano il volo,
sognando nella brezza profumata.
Questo
distico modula a La magg. e raggiunge la Dominante sospesa di Fa diesis.
La melodia
di Zwei Lerchen nur noch steigen
recupera un frammento già presentato come controcanto
nell'introduzione; esso viene riutilizzato anche nella transizione fra Seconda
e Terza Strofa, nonché per il primo verso di quest'ultima

Esempio-5
Il motivo
legato a Lerchen è fortemente caratterizzato, a
livello strumentale, dalla presenza dei trilli, fattore che verrà rievocato
alla fine del Lied.
- Terza Strofa
(b.33-53)
Tritt her und laß sie schwirren,
Bald ist es
Schlafenszeit,
Vieni qui, e lascia che si librino,
presto sarà il tempo del sonno,
La
Dominante di Fa diesis che conclude la strofa precedente viene fatta risolvere
sulla Dominante di Mi bem magg.,
tonalità stabile per i primi due versi, ancora punteggiati dai trilli, ben più
rarefatti, a suggerire acutamente quanto semplicemente l'allontanamento e la
marginalità del volo delle allodole.
Daß wir
uns nicht verirren
In dieser Einsamkeit.
che noi non ci perdiamo
in questa solitudine.
Sul verbo verirren riscontriamo l'arditezze armonica più sorprendenti
del ciclo: da un'appoggiatura non risolta, afferente alla Sottodominante di Mi bem, divenuto nel frattempo minore, si transita
direttamente alla quarta e sesta di Sol minore; quindi attraverso una discesa
cromatica, al II grado e infine alla Dominante di Si bem
magg. (su Einsamkeit)
- Quarta
Strofa (b.55-74)
O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot,
O vasta pace silenziosa,
così profonda nel rosso d
Il Si bem magg. di arrivo viene lentamente condotto a fungere da
Dominante di Mi bem magg.
Così il
ritorno alla tonalità d'impianto dalla sua Dominante delinea il percorso di
ritorno rispetto alla modulazione che chiude la prima strofa. Questi due
collegamenti, I-V e V-I, sono i due cardini dell'iter tonale del brano: in un
linguaggio armonico che abbiamo constatato essere così denso di cromatismi e
connessioni anticonvenzionali viene scelto il legame più tradizionale per
sottolineare i punti di svolta della narrazione, l'apparire dell'ultimo sogno
vitale e lo sprofondamento finale nella pace che sta per divenire eterna, quasi
ad esprimere quanto sia semplice l'accettazione della morte da parte delle due
anime così intimamente pacificate.
Il senso
del ritorno è splendidamente reso dalla ripresa orchestrale dell'inizio del
Tema 1 sul secondo verso.
Wie sind
wir wandermüde -
Siamo così stanchi del viaggio –
Lo
slittamento cromatico da Mi bem min. a Re magg. offre
lo spazio per la prima reminiscenza del tema della Trasfigurazione di Tod und Verklärung.
Ist dies etwa der Tod?
È questo, forse, la morte?
Al termine
di questo fatale interrogativo si raggiunge, attraverso Si bem
min., la quarta e sesta di Do bem
magg., fondamento della seconda citazione del tema
della Trasfigurazione.
La lunga e
commovente coda orchestrale ripresenta scivolamenti cromatici fra Mi bem magg. e Re magg., e
inversamente fra Re min. e Mi bem magg.,
che sull'ultimo segmento viene fatto oscillare fra Do bem
magg. e Do min., dunque sul sesto abbassato e sul
sesto come già notato per il finale di Tod und Verklärung. Se pensiamo che più o meno evidenti
allusioni al poema sinfonico del 1889 si possono riscontrare anche in Metamorphosen, l'altra pietra miliare della vecchiaia
straussiana, possiamo agevolmente comprendere quanto quell'opera sia stata importante nel percorso creativo del
compositore, e quanto gli sia rimasta impressa nella riflessione esistenziale,
probabilmente come uno dei più importanti simboli della riuscita di quella
missione dell'artista che proprio quel poema intende ilustrare.
È forse
anche merito di questo pensiero consolante se lo stato d'animo da cui nascono i
Vier letzte Lieder è così fiducioso nella serenità della dipartita.
Ascoltando
le ultime due armonie di Im Abendrot, niente
di più e niente di meno di una cadenza V-I, mentre svaniscono gli ultimi,
remoti fremiti dei trilli, ci piace immaginare che da un conoscitore
dell'universo culturale schumanniano, quale Strauss era, si sia levato un pensiero al verso finale del Manfred di Byron: "Old man, 't is not so difficult to die."
Traduzioni italiane a cura
di Fabio Grasso
Foto di apertura:
Caspar
David Friedrich, Die Lebensstufen, 1834
Visita la pagina
fonte dell'immagine
Home www.rosenfinger.com